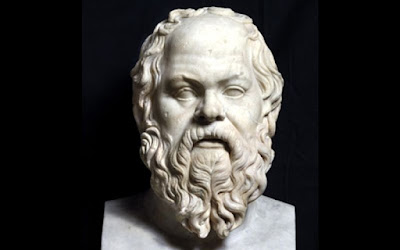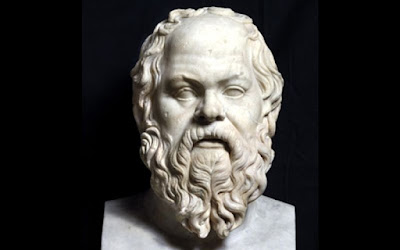LA GRECIA ARCAICA E I POEMI DI OMERO
Le testimonianze più antiche di una qualche forma di educazione provenienti da quest'area sono i miti. In particolare sono giunti fino a noi due poemi: l'Iliade e l'Odissea.
I poemi sono grandi narrazioni di personaggi eroici. L'Iliade e l'Odissea sono attribuite a un cantore cieco: Omero. In realtà, non si sa molto di questo personaggio e se ne mette in dubbio la reale esistenza. Omero non ha fatto altro che raccogliere e unificare leggende precedenti diffuse nell'area greca. Nei poemi omerici compare il concetto di areté. Questo termine significa la virtù nel sensodi capacità o abilità. Esistono quindi varie areté.
L'Iliade racconta l'assedio della città di Troia, in Asia Minore a opera degli Achei: qui ci troviamo di fronte all'areté guerriera. Gli eroi sono esempi, modelli educativi di virtù belliche.
L'Odissea narra delle peregrinazioni attraverso il Mediterraneo di Ulisse. Si può dire che quest'opera prevalga l'areté intellettuale.
ESIODO E L'ARETE' DEL MONDO CONTADINO
Accanto a Omero va ricordato Esiodo. Per un periodo è stata negata una vera unità alle sue opere più famose, la Teogonia e le Opere e i giorni, considerate soltanto un ''assemblaggio di poesie''.
Nella Teogonia, un poema in 1022 versi forse incompiuto, Esiodo, dopo aver parlato dell'origine dell'universo, elenca le generazioni degli dei corrispondenti ai tre periodi della storia del mondo: Urano, Crono, Zeus.
Nelle Opere vengono affrontati i due concetti fondamentali del lavoro e della giustizia, esposti riccorendo al mito di Prometeo e a quello delle cinque età degli uomini. oltre alle esortazioni al lavoro e alla giustizia sono presenti consigli di morale e di economia; seguono i precetti sui lavori agricoli e sulla navigazione e infine i consigli per il matrimonio e i rapporti con gli amici. L'areté descritta da Esiodo è dunque quella del mondo contadino greco delle origini.

I SOFISTI E LA NASCITA DELLA PAIDE'IA
Sotto la guida di Pericle, ma anche nei decenni successivi, la città è il luogo di attività dei principali protagonisti della cultura greca del periodo, i sofisti, Socrate e Platone.
Il termine sofista indica i primi insegnanti a pagamento degli aspiranti politici. I sofisti intendono insegnare l'areté politica, cioè la tecnica con cui un uomo politico può sostenere in pubblico le proprie tesi e sconfiggere quelle degli avversari. La nuova virtù consiste nell'abilità dialettica e retorica, cioè nell'arte del linguaggio.
Le tecniche insegnate dai sofisti sono due:
- la dialettica, che consiste in un serrato dialogo tra due o più interlocutori, nel quale ciascuno cerca di provare razionalmente la validità delle proprie posizioni confutando quelle dell'avversario;
- la retorica, che consiste in lunghi discorsi con i quali persuadere un vasto uditorio.
E' importante notare che i sufisti non identificano la conoscenza con la verità:
- Protagora di Abdera afferma: "L'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono"; ciò significa che la verità è quella che gli uomini decidono sia tale;
- Gorgia da Lentini afferma a sua volta: "Nulla è; seppure qualcosa è, non è conoscibile seppure conoscibile, non è comunicabile"; quindi tutto sta nelle nostre capacità di persuasione.
Per queste parole i sofisti sono stati accusati di scetticismo, perchè hanno affermato che non è possibile conoscere nulla con certezza, e di nichilismo, perchè hanno affermato che non esistono verità assolute. Essi hanno però avuto il grande merito di contribuire alla democratizzazione della politica e del sapere, sostenendo l'insegnabilità della virtù a tutti e di conseguenza l'importanza dell'istruzione e dell'educazione. Essi dunque hanno posto l'uomo e la città al centro della loro attenzione filosofica e nella polis sono stati i primi insegnanti di professione che si sono dedicati alla formazione dell'uomo politico.
SOCRATE: LA FORZA DEL DIALOGO
Una delle figure fondamentali per lo sviluppo non solo della pedagogia, ma di tutto il pensiero occidentale: Socrate. Socrate dedica la sua vita alla filosofia; ai suoi allievi non trasmette un insegnamento tecnico, ma morale. Socrate insegna ai suoi interlocutori che molte loro convinzioni sono solo opinioni infondate e li conduce alla continua ricerca della verità. Socrate attraverso il dialogo sottopone gli interlocutori ad un complesso gioco di domande e di risposte, mettendo alla prova le loro convinzioni. Sotto i colpi delle obiezioni di Socrate, le tesi degli avversari crollano, perchè si rivelano contraddittorie. Questa confutazione apre la strada ad un'autentica ricerca della verità. Questo aspetto del metodo socratico è chiamato maieutica, un termine che in greco indica l'arte della levatrice. Socrate infatti paragona la propria attività a quella di sua madre, che era una levatrice; come la madre aiuta le donne a partorire corpi, così Socrate aiuta le menti a partorire idee. Ma il pensatore ateniese non possiede quella verità che induce a cercare. Egli si proclama ignorante, con un atteggiamento che viene definito ironia socratica. Socrate è considerato lo scopritore dell'anima come coscienza: l'uomo è la propria anima e l'anima è la sede dell'attività pensante e dell'attività morale. I veri valori, per Socrate, non sono i beni esteriori; i valori da coltivare sono quelli dell'anima, e in primo luogo la conoscenza; è in questo modo che l'essere umano ottiene la libertà e la felicità. La posizione di Socrate prende il nome di ottimismo etico, ed è stata ritenuta intellettualistica, perchè, appunto, si affida alla ragione e alla conoscenza, e sui presunti benefici immediati che ne dovrebbero conseguire.